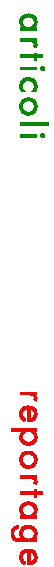
|
Reportage
24 aprile 2011 - Cronache - Italia - Il Giornale |
|
| Feriti d'Italia |
«È stato come un pugno sferrato con un guanto d’acciaio. Non dimenticherò mai la sensazione, fredda, metallica del proiettile penetrato vicino all’orecchio, da destra e uscito dal collo, a sinistra. Il sangue mi ha riempito subito la bocca e ho pensato: «Sono gli ultimi secondi della mia vita ». Il caporal maggiore Gianluca Ricatti, 24 anni, del183˚ reggimentoparacadutisti Nembo, racconta così il suo ferimento in Afghanistan. Il 24 settembre 2009 il suo convoglio si stava avvicinando ad un villaggio nella famigerata valle di Zirko, quando è scattata l’imboscata. «Sentivo i fischi dei proiettili, che schizzavano a terra davanti ai mezzi blindati. Ad una quarantina di metri esplodevano le granate di mortaio - ricorda il parà- Ero in ralla , fuori dalla botola e rispondevo al fuoco con la mitragliatrice».Un proiettile di kalashnikov gli trapassa il collo e crolla dentro il blindato Lince. Chi lo soccorre lo dà per spacciato. «Invece sono un miracolato. Nessuna lesione permanente e ho recuperato completamente. Adesso tutti mi considerano un amuleto vivente» spiega il fuciliere con barbetta e basco amaranto. La cicatrice sul collo resterà per sempre, ma Ricatti ha voluto tornare da oltre un mese in Afghanistan con i paracadutisti della Folgore.
Negli ultimi dieci anni di «guerre» di pace hanno perso la vita 53 soldati italiani, ma oltre 150 sono rimasti feriti. Nulla rispetto ai sanguinosi conflitti del passato e alle migliaia di morti fra i civili iracheni e afghani, ma dei feriti d’Italia sappiamo e ne parliamo poco. In gran parte sono ragazzi poco più che ventenni feriti in combattimento o saltati per aria sulle trappole esplosive. A Il Giornale raccontano le loro storie di «miracolati» o dilaniati per sempre nelle carni ed impegnati nella battaglia per ricostruirsi una vita.
Il caporal maggiore degli alpini Cristina Buonacucina, 27 anni, non è donna che si lagna. Il 17 maggio scorso avanzava verso Bala Murghab sul fronte nord nell’Afghanistan occidentale controllato dagli italiani, con una colonna di 140 mezzi. «Ricordo un tonfo sordo e poi ho perso i sensi per una decina di secondi. Mi ha risvegliato la voce di Gianfranco, che era stato sbalzato fuori dal Lince dall’esplosione e urlava: «Cristina, Cristina» racconta il sottufficialedellacompagniaValanga, 32˚ reggimento Genio guastatori. Per il sergente maggiore Massimiliano Ramadù ed il caporal maggiore scelto Luigi Pascazio, seduti davanti,non c’era più nulla da fare.
«Il mio piede sinistro era girato dall’altra parte e vedevo la tibia, uscita dalla carne, incastrata fra le lamiere. - spiega Cristina, capelli corti e stampelle -Avevo paura, urlavo e mi preoccupavo del piede, che mi rimanesse attaccato ». Tirata fuori ed evacuata in elicottero il caporal maggiore è la prima donna feritagravemente in zona di operazioni. Per uscire dal tunnel ci è voluto tempo: «In un letto d’ospedale i primi giorni temi di chiudere gli occhi perchè rivedi tutta la scena. Mi svegliavo con la nausea e se una porta sbatteva sobbalzavo». Cristina ora combatte con la riabilitazione per tornare a camminare senza stampelle e rimanere nell’esercito.
La Difesa non ha voluto fornire le fotografie dei nostri soldati inzuppati di sangue. Secondo qualche generale sono immagini «inopportune». Il sangue dei feriti in incidenti stradali o disastri vari si può far vedere, ma quello dei militari impegnati nelle «guerre» di pace no.
«È strano, non so quante persone ci fossero attorno tra talebani che sparavano, militari italiani che rispondevano al fuoco e personale vicino al mezzo colpito, ma con Luca mi sembrava di parlare come se fossi in una stanza insonorizzata» ricorda il tenente colonnello medico degli alpini Federico Lunardi. Il 9 ottobre 2010, nella valle della morte in Gulistan, durante una furiosa battaglia con i talebani, un blindato Lince salta in aria. Dei soldati a bordo quattro vengono uccisi. Si salva solo il caporal maggiore Luca Cornacchia, grazie ad un valoroso intervento sotto il fuoco di Lunardi, che gli presta i primi soccorsi. «Dopo avermi passato il fucile, il momento più toccante è stato quando mi ha messo in mano la fotografia del suo bambino di due anni con su scritto “al mio amore” »racconta l’ufficiale medico. Lunardi ha parlato con diversi feriti d’Italia e da questi incontri potrebbe nascere un libro, il primo di questo genere dalla fine della seconda guerra mondiale. A 25 anni, il caporal maggiore Stefano La Mattina, piemontese doc, con il diploma di perito elettrotecnico, poteva trovare un lavoro tranquillo: «Mi sono arruolato perchè è una scelta di vita. Ne sono convinto anche dopo essere stato ferito il 23 settembre 2009 in Afghanistan » sottolinea il paracadutista dell’11˚ compagnia Peste, 186˚ reggimento della brigata Folgore. «Sentivo il ticchettio metallico dei proiettili che colpivano il blindato.Stavo ricaricando l’arma quando i rumori della battaglia sono scomparsi, a parte un tonfo fortissimo. Ero stato colpito al braccio sinistro. Il proiettile entrato vicino al gomito era uscito dalla spalla per conficcarsi sul portellone del Lince. I miei compagni di squadra l’hanno conservato per scaramanzia» spiega il caporal maggiore davanti al monumento ai caduti di El Alamein. Sul campo di battaglia lo hanno trasportato a braccia, in barella, fino ad un elicottero per evacuarlo. «A bordo una tenente medico spagnola mi schiaffeggiava urlando: «Non dormire, non dormire» ricorda La Mattina, che aveva perso molto sangue. Dall’ospedale di campo di Herat ha cercato di indorare la pillola ai genitori dicendo che si è fatto male cadendo dal blindato. «Claudia, mia madre, mi ha subito detto: questa storia mi puzza» racconta il caporal maggiore con il braccio ancora fasciato e appeso al collo.
Qualcuno fra i feriti d’Italia si lamenta del labirinto amministrativo e delle spese legali per ottenere quello che spetta loro. Tutti vengono seguiti da vicino per le cure ospedaliere e psicologiche. Vittorio De Rasis ferito gravemente nella strage di Nassiryah del 2003 ha lasciato i carabinieri, ma le cicatrici dell’Irak restano.«Non ci invitano neppure più alla commemorazione ufficiale - osserva il luogotenente in congedo- Ci sono i caduti, ma anche noi feriti abbiamo versato il sangue per la patria ».
Simone Careddu, 30 anni, della compagnia Angeli neri, è saltato in aria in Afghanistan sulla statale 517.I soldati italiani l’avevano ribattezzata l’autostrada per l’inferno.Per il caporal maggiore dell’8˚ reggimento Genio guastatori di Legnago, costretto ad una sedia a rotelle, ma abituato a lanciarsi con il paracadute, la vera battaglia, al fianco di sua moglie Tiziana, inizia adesso.
Il 14 luglio 2009 il suo Lince è stato fatto a pezzi da troppi chili di esplosivo. Il tetto è volato via assieme al caporal maggiore scelto Alessandro Di Lisio morto sul colpo. «Non ricordo il boom, ma una nuvola di polvere nera ed il calore. Ho irrigidito i muscoli e si è spenta la luce. Mi sono ritrovato a terra a fianco del mezzo» racconta il guastatore. «Mi bruciavano gli occhi per colpa della nafta e avevo difficoltà a respirare. Il braccio destro era spezzato.- ricorda il giovane sardo- Sentivo il dolore dietro la schiena, come se ci fosse una pietra conficcata. E dicevo ai soccorritori levatemela, ma non c’era nulla.Ho capito subito che non sarei mai tornato a camminare ». Simone ci offre un caffè nell’appartamento della Difesa a Verona, attrezzato per lui inchiodato alla carrozzella. «Vorrei tanto restare sotto le armi spiega il coraggioso parà- È stato il mio sogno fin da bambino. Quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande rispondevo sempre: il soldato».
www.faustobiloslavo.eu |
| |
|
video
|
|
|
14 maggio 2020 | Tg5 | reportage
Trieste, Lampedusa del Nord Est
Fausto Biloslavo
TRIESTE - Il gruppetto è seduto sul bordo della strada asfaltata. Tutti maschi dai vent’anni in su, laceri, sporchi e inzuppati di pioggia sembrano sfiniti, ma chiedono subito “dov’è Trieste?”. Un chilometro più indietro passa il confine con la Slovenia. I migranti illegali sono appena arrivati, dopo giorni di marcia lungo la rotta balcanica. Non sembra il Carso triestino, ma la Bosnia nord occidentale da dove partono per arrivare a piedi in Italia. Scarpe di ginnastica, tute e qualche piumino non hanno neanche uno zainetto. Il più giovane è il capetto della decina di afghani, che abbiamo intercettato prima della polizia. Uno indossa una divisa mimetica probabilmente bosniaca, un altro ha un barbone e sguardo da talebano e la principale preoccupazione è “di non venire deportati” ovvero rimandati indietro. Non sanno che la Slovenia, causa virus, ha sospeso i respingimenti dall’Italia. Di nuovo in marcia i migranti tirano un sospiro di sollievo quando vedono un cartello stradale che indica Trieste. Il capetto alza la mano in segno di vittoria urlando da dove viene: “Afghanistan, Baghlan”, una provincia a nord di Kabul.
Il 12 maggio sono arrivati in 160 in poche ore, in gran parte afghani e pachistani, il picco giornaliero dall’inizio dell’anno. La riapertura della rotta balcanica sul fronte del Nord Est è iniziata a fine aprile, in vista della fase 2 dell’emergenza virus. A Trieste sono stati rintracciati una media di 40 migranti al giorno. In Bosnia sarebbero in 7500 pronti a partire verso l’Italia.
Il gruppetto di afghani viene preso in carico dai militari del reggimento Piemonte Cavalleria schierato sul confine con un centinaio di uomini per l’emergenza virus. Più avanti sullo stradone di ingresso in città, da dove si vede il capoluogo giuliano, la polizia sta intercettando altri migranti. Le volanti con il lampeggiante acceso “scortano” la colonna che si sta ingrossando con decine di giovani stanchi e affamati. Grazie ad un altoparlante viene spiegato in inglese di stare calmi e dirigersi verso il punto di raccolta sul ciglio della strada in attesa degli autobus per portarli via. Gli agenti con le mascherine controllano per prima cosa con i termometri a distanza la temperatura dei clandestini. Poi li perquisiscono uno ad uno e alla fine distribuiscono le mascherine ai migranti. Alla fine li fanno salire sugli autobus dell’azienda comunale dei trasporti cercando di non riempirli troppo per evitare focolai di contagio. “No virus, no virus” sostiene Rahibullah Sadiqi alzando i pollici verso l’alto in segno di vittoria. L’afghano è partito un anno fa dal suo paese e ha camminato per “dodici giorni dalla Bosnia, attraverso la Croazia e la Slovenia fino all’Italia”. Seduto per terra si è levato le scarpe e mostra i piedi doloranti. “I croati mi hanno rimandato indietro nove volte, ma adesso non c’era polizia e siamo passati tutti” spiega sorridendo dopo aver concluso “il gioco”, come i clandestini chiamano l’ultimo tratto della rotta balcanica.
“Abbiamo registrato un crollo degli arrivi in marzo e per gran parte di aprile. Poi un’impennata alla fine dello scorso mese fino a metà maggio. L’impressione è che per i paesi della rotta balcanica nello stesso periodo sia avvenuta la fine del lockdown migratorio. In pratica hanno aperto i rubinetti per scaricare il peso dei flussi sull’Italia e sul Friuli-Venezia Giulia in particolare creando una situazione ingestibile anche dal punto di vista sanitario. E’ inaccettabile” spiega l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, che punta il dito contro la Slovenia.
Lorenzo Tamaro, responsabile provinciale del Sindacato autonomo di polizia, denuncia “la carenza d’organico davanti all’emergenza dell’arrivo in massa di immigrati clandestini. Rinnoviamo l’appello per l’invio di uomini in rinforzo alla Polizia di frontiera”.
In aprile circa il 30% dei migranti che stazionavano in Serbia è entrato in Bosnia grazie alla crisi pandemica, che ha distolto uomini ed energie dal controllo dei confini. Nella Bosnia occidentale non ci sono più i campi di raccolta, ma i migranti bivaccano nei boschi e passano più facilmente in Croazia dove la polizia ha dovuto gestire l’emergenza virus e pure un terremoto.
Sul Carso anche l’esercito impegnato nell’operazione Strade sicure fa il possibile per tamponare l’arrivo dei migranti intercettai pure con i droni. A Fernetti sul valico con la Slovenia hanno montato un grosso tendone mimetico dove vengono portati i nuovi arrivati per i controlli sanitari. Il personale del 118 entra con le protezioni anti virus proprio per controllare che nessuno mostri i sintomi, come febbre e tosse, di un possibile contagio. Il Sap è preoccupato per l’emergenza sanitaria: “Non abbiamo strutture idonee ad accogliere un numero così elevato di persone. Servono più ambienti per poter isolare “casi sospetti” e non mettere a rischio contagio gli operatori di Polizia. Non siamo nemmeno adeguatamente muniti di mezzi per il trasporto dei migranti con le separazioni previste dall’emergenza virus”.
Gli agenti impegnati sul terreno non sono autorizzati a parlare, ma a denti stretti ammettono: “Se va avanti così, in vista della bella stagione, la rotta balcanica rischia di esplodere. Saremo travolti dai migranti”. E Trieste potrebbe trasformarsi nella Lampedusa del Nord Est.
|
|
|
|
|
24 novembre 2015 | Rai 1 Storie vere | reportage
Terrorismo in Europa
Dopo gli attacchi di Parigi cosa dobbiamo fare per estirpare la minaccia in Siria, Iraq e a casa nostra
|
|
|
|
|
05 aprile 2020 | Tg5 | reportage
Virus, il fronte che resiste in Friuli-Venezia Giulia
Fausto Biloslavo
TRIESTE - “Anche noi abbiamo paura. E’ un momento difficile per tutti, ma dobbiamo fare il nostro dovere con la maggiore dedizione possibile” spiega Demis Pizzolitto, veterano delle ambulanze del 118 nel capoluogo giuliano lanciate nella “guerra” contro il virus maledetto. La battaglia quotidiana inizia con la vestizione: tuta bianca, doppi guanti, visiera e mascherina per difendersi dal contagio. Il veterano è in coppia con Fabio Tripodi, una “recluta” arrivata da poco, ma subito spedita al fronte. Le due tute bianche si lanciano nella mischia armati di barella per i pazienti Covid. “Mi è rimasta impressa una signora anziana, positiva al virus, che abbiamo trasportato di notte - racconta l’infermiere Pizzolitto - In ambulanza mi ha raccontato del marito invalido rimasto a casa. E soffriva all’idea di averlo lasciato solo con la paura che nessuno si sarebbe occupato di lui”.
Bardati come due marziani spariscono nell’ospedale Maggiore di Trieste, dove sono ricoverati un centinaio di positivi, per trasferire un infetto che ha bisogno di maggiori cure. Quando tornano caricano dietro la barella e si chiudono dentro l’ambulanza con il paziente semi incosciente. Si vede solo il volto scavato che spunta dalle lenzuola bianche. Poi via a sirene spiegate verso l’ospedale di Cattinara, dove la terapia intensiva è l’ultima trincea per fermare il virus.
Il Friuli-Venezia Giulia è il fronte del Nord Est che resiste al virus grazie a restrizioni draconiane, anche se negli ultimi giorni la gente comincia ad uscire troppo di casa. Un decimo della popolazione rispetto alla Lombardia ha aiutato a evitare l’inferno di Bergamo e Brescia. Il 4 aprile i contagiati erano 1986, i decessi 145, le guarigioni 220 e 1103 persone si trovano in isolamento a casa. Anche in Friuli-Venezia Giulia, come in gran parte d’Italia, le protezioni individuali per chi combatte il virus non bastano mai. “Siamo messi molto male. Le stiamo centellinando. Più che con le mascherine abbiamo avuto grandi difficoltà con visiere, occhiali e tute” ammette Antonio Poggiana, direttore generale dell’Azienda sanitaria di Trieste e Gorizia. Negli ultimi giorni sono arrivate nuove forniture, ma l’emergenza riguarda anche le residenze per anziani, flagellate dal virus. “Sono “bombe” virali innescate - spiega Alberto Peratoner responsabile del 118 - Muoiono molti più anziani di quelli certificati, anche 4-5 al giorno, ma non vengono fatti i tamponi”.
Nell’ospedale di Cattinara “la terapia intensiva è la prima linea di risposta contro il virus, il nemico invisibile che stiamo combattendo ogni giorno” spiega Umberto Lucangelo, direttore del dipartimento di emergenza. Borse sotto gli occhi vive in ospedale e da separato in casa con la moglie per evitare qualsiasi rischio. Nella trincea sanitaria l’emergenza si tocca con mano. Barbara si prepara con la tuta anti contagio che la copre dalla testa ai piedi. Un’altra infermiera chiude tutti i possibili spiragli delle cerniere con larghe strisce di cerotto, come nei film. Simile ad un “palombaro” le scrivono sulla schiena il nome e l’orario di ingresso con un pennarello nero. Poi Barbara procede in un’anticamera con una porta a vetri. E quando è completamente isolata allarga le braccia e si apre l’ingresso del campo di battaglia. Ventuno pazienti intubati lottano contro la morte grazie agli angeli in tuta bianca che non li mollano un secondo, giorno e notte. L’anziano con la chioma argento sembra solo addormentato se non fosse per l’infinità di cannule infilate nel corpo, sensori e macchinari che pulsano attorno. Una signora è coperta da un telo blu e come tutti i pazienti critici ripresa dalle telecamere a circuito chiuso.
Mara, occhioni neri, visiera e mascherina spunta da dietro la vetrata protettiva con uno sguardo di speranza. All’interfono racconta l’emozione “del primo ragazzo che sono riuscito a svegliare. Quando mi ha visto ha alzato entrambi i pollici in segno di ok”. E se qualcuno non ce la fa Mara spiega “che siamo preparati ad accompagnare le persone verso la morte nella maniera più dignitosa. Io le tengo per mano per non lasciarle sole fino all’ultimo momento”.
Erica Venier, la capo turno, vuole ringraziare “con tutto il cuore” i triestini che ogni giorno fanno arrivare dolci, frutta, generi di conforto ai combattenti della terapia intensiva. Graziano Di Gregorio, infermiere del turno mattutino, è un veterano: “Dopo 22 anni di esperienza non avrei mai pensato di trovarmi in una trincea del genere”. Il fiore all’occhiello della rianimazione di Cattinara è di non aver perso un solo paziente, ma Di Gregorio racconta: “Infermieri di altre terapie intensive hanno dovuto dare l’estrema unzione perchè i pazienti sono soli e non si può fare diversamente”.
L’azienda sanitaria sta acquistando una trentina di tablet per cercare di mantenere un contatto con i familiari e permettere l’estremo saluto. Prima di venire intubati, l’ultima spiaggia, i contagiati che hanno difficoltà a respirare sono aiutati con maschere o caschi in un altro reparto. Il direttore, Marco Confalonieri, racconta: “Mio nonno era un ragazzo del ’99, che ha combattuto sul Piave durante il primo conflitto mondiale. Ho lanciato nella mischia 13 giovani appena assunti. Sono i ragazzi del ’99 di questa guerra”.
|
|
|
|
radio

|
03 gennaio 2011 | Radio Capodistria - Storie di bipedi | intervento |
Italia
Gli occhi della guerra
Le orbite rossastre di un bambino soldato, lo sguardo terrorizzato di un prigioniero che attende il plotone di esecuzione, l’ultimo rigagnolo di vita nelle pupille di un ferito sono gli occhi della guerra incrociati in tanti reportage di prima linea.
Dopo l’esposizione in una dozzina di città la mostra fotografica “Gli occhi della guerra” è stata inaugurata a Trieste. Una collezione di immagini forti scattate in 25 anni di reportage da Fausto Biloslavo, Gian Micalessin e Almerigo Grilz, ucciso il 19 maggio 1987 in Mozambico, mentre filmava uno scontro a fuoco. La mostra, che rimarrà aperta al pubblico fino al 20 gennaio, è organizzata dall’associazione Hobbit e finanziata dalla regione Friuli-Venezia Giulia. L’esposizione è dedicata a Grilz e a tutti i giornalisti caduti in prima linea. Il prossimo marzo verrà ospitata a Bruxelles presso il parlamento europeo.Della storia dell'Albatross press agency,della mostra e del libro fotografico Gli occhi della guerra ne parlo a Radio Capodistria con Andro Merkù.
|
|
|
|
|